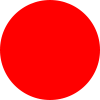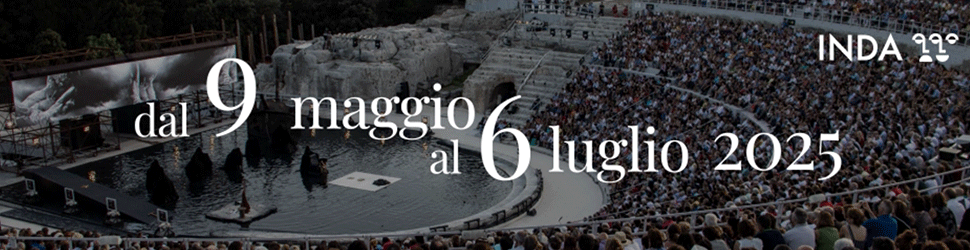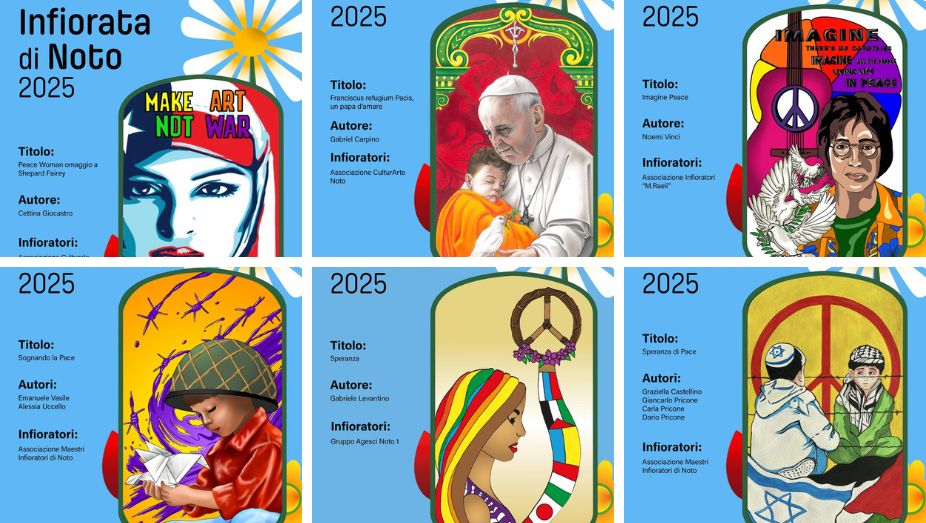[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Convivio, rubrica a cura di Mario Blancato”][vc_single_image image=”9695″ img_size=”large” css_animation=”fadeInLeft”][vc_column_text]Il termine lessico, che compare nel titolo del libro di Sandra Petrignani, edito da Laterza nel 2019, evoca, immediatamente, l’idea di un repertorio di lemmi, uno strumento di non sempre facile consultazione: quante volte nei dizionari, in particolare se si tratta di dizionari di una lingua straniera, non nostra, ci si perde? O perché una parola non la si trova, o perché non si è sicuri del significato che essa, in un dato contesto, abbia. Al termine lessico Sandra Petrignani associa un aggettivo che è estremamente eloquente: femminile. La nostra autrice, infatti, costruisce il suo libro intorno a parole con le quali ci racconta l’universo delle donne attraverso una loro particolare categoria: non donne qualsiasi, ma donne che, nella scrittura, hanno trovato il loro linguaggio. Donne che, delle parole, hanno fatto le loro ancelle. Con queste donne l’autrice conversa amabilmente, servendosi di una selezione assai raffinata e variegata di passi tratti dalle loro creazioni letterarie. Ma quali sono, nello specifico, le parole con cui Sandra Petrignani ha scelto di riempire il suo Lessico femminile?
[/vc_column_text][vc_column_text]Si tratta di termini, che poi corrispondono al titolo di ciascun capitolo del libro, dall’ampio spettro semantico. Sono sostantivi comuni, che ci capita spesso di usare quando parliamo, parole come casa, cose, amore, relazioni, madri, figli, verità, tempo. Oltre a questi sostantivi c’è un unico pronome, lei, che dà il titolo a due dei capitoli centrali del libro: qui l’autrice esplora la dinamica delle relazioni tra donna – uomo (Lei per lui), e donna-donna (Lei per lei). Come il sostantivo che troviamo nel titolo del libro è definito dall’aggettivo femminile, anche quelli che troviamo nei singoli capitoli si accompagnano a degli aggettivi o a delle parole che servono a definirne l’esteso campo semantico: e così la casa è pulita, le cose sono insignificanti, l’amore è inventato, le relazioni sono pericolose, le madri sono tali se esiste la categoria dei figli e questi ultimi sono tali se esiste la categoria delle madri, la verità è da dire, costi quel che costi, il tempo svela le solitudini.
Nel primo capitolo la nostra autrice ci guida all’interno delle case di queste donne scrittrici. Sono luoghi importanti per loro, più di quanto non possano esserlo per gli uomini che spesso, con le loro case, non si identificano. La Petrignani dice che “la casa, per una donna, è l’estensione della sua anima, un modo di esprimersi”. Questo rapporto simbiotico non può certo sorprenderci se pensiamo per quanto tempo le case sono state l’unico scenario possibile nell’esistenza delle donne. Ma queste case non sono più prigione, luogo di esclusione dalla vita sociale, ma spazio aperto, proiettato sia verso l’esterno, sia al suo stesso interno. “Mi domando se mai una donna scrittrice potrebbe tenere chiusa ai figli, che la reclamano, la porta del suo studio”, precisa la nostra autrice, ricordando come la scrivania alla quale lavorava Jane Austen si trovasse al centro di una stanza rumorosa, dove tutti potevano disturbarla. Questa immagine acquista ancora più forza se la si confronta con una fotografia da cui la Petrignani fu colpita durante una mostra su Simenon. Tale fotografia rappresentava una bambina, bionda, molto bella, che saltellava dinanzi alla porta chiusa dello studio del padre: questa bambina era la figlia di Simenon.
Sappiamo bene che le case, soprattutto quelle delle donne, sono piene di oggetti, di cose tra le più disparate, spesso insignificanti. Ed è alle cose che è dedicato il secondo capitolo del libro: attraverso un’antologia raffinata di testi letterari, l’autrice sembra tracciare una linea immaginaria che lega indissolubilmente le cose che popolano la quotidianità delle scrittrici (si pensi ad una pagina di Lady Oracolo della Atwood, in cui un personaggio, una romanziera, si muove spedita tra scrivania e biancheria da lavare); le parole intorno alle quali ruota la loro scrittura letteraria (delicatissima la citazione della poesia “Come sono piccole le cose che mi piacciono” contenuta in Leggere Lolita a Teheran di Azar Nafisi) e la banalità della morte. Qualcuno potrebbe strabuzzare gli occhi dinanzi a questa affermazione: eppure non c’è da sorprendersi. Di rado si muore eroicamente; per lo più il
nostro trapasso -osserva la Petrignani-, avviene in modo insignificante, a causa di una malattia prevedibile, o per una banale casualità, o per sciocca distrazione.
L’esordio del capitolo dedicato intitolato all’amore (inventato) non può che prendere le mosse dalla più grande poetessa di tutti i tempi. Scrive la Petrignani: “In principio fu Saffo. Fu a lei a mettere in versi indimenticabili l’ossessione d’amore”. Il riferimento è ad un frammento in cui la poetessa di Lesbo descrive con dovizie di particolari la somatizzazione di un sentimento che distrugge chi lo prova, la gelosia: con un climax ascendente Saffo mette in versi l’afasia, le allucinazioni sonore e visive, l’aumento della temperatura del corpo, l’abbassamento della pressione che la porta quasi a svenire: tutte conseguenze, queste, della visione di un uomo che corteggia, forse ricambiato, la giovane fanciulla oggetto della sua passione. Il frammento di Saffo fa da apripista a tutta una serie di passi di romanzi che hanno per protagoniste delle donne affette da una malattia che Grace Paley, in Più tardi nel pomeriggio, chiama la lui-te.
La Petrignani ci spiega di che malattia si tratti: “la lui-te è la centralità del maschio nella vita delle donne, nei loro pensieri, nei loro discorsi. Probabilmente è la lui-te a scatenare l’invenzione di un uomo fuori dal comune, decisivo, salvifico e fatale. Un’invenzione che, come tale, è sganciata dalle caratteristiche reali dell’oggetto della passione.” A causa di questa malattia, la donna avrebbe una tendenza naturale, incontrollabile, a dare forma nella sua immaginazione ad uomo che non esiste. L’uomo che ama è soltanto un eidolon, come direbbero i greci, una visione inconsistente e inafferrabile. E quell’eidolon è per lei un idolo, nel senso odierno del termine, ovvero un oggetto di ammirazione e di dedizione fanatica, che la porterà a cadere in quello che, come ci ricorda la Petrignani, la Ginzburg chiama “pozzo nero”.
Nel capitolo intitolato Madri (e figli) la nostra autrice si addentra nei meandri di un altro rapporto complesso. Le madri che incontriamo in queste pagine assomigliano alle scrittrici dalla cui penna sono nate. Nella dettagliata disamina che ci viene offerta, questa relazione può configurarsi in vari modi: ora assume i connotati di un rapporto simbiotico; ora quelli di un rapporto complice ma privo degli eccessi causati da un atteggiamento di totale abnegazione; ora quelli di un rapporto contrassegnato da continue tensioni, che possono arrivare ad assumere le forme della manipolazione dell’altro. Non mancano poi i casi in cui si arriva a fuggire l’idea di maternità: si pensi alla De Beauvoir che, probabilmente, sapeva bene che la scrittura è una maternità metaforica, dunque uno strumento alternativo per potere essere madri. Qualcuno potrebbe, tuttavia, affermare che quella letteraria è una maternità che anche gli uomini possono permettersi. Eppure, quello che le scrittrici hanno con i personaggi che creano, è un rapporto speciale, unico. Le parole con cui una scrittrice fa nascere le sue creature letterarie sono inaccessibili alla lingua di uno scrittore uomo: “sono grondanti carnalità e placenta e paura dell’imperfezione”- dice la Petrignani. Parole, dunque, che conservano la memoria di un’esperienza ancestrale tutta femminile, da cui l’uomo è, per natura, escluso.
[/vc_column_text][vc_single_image image=”9696″ img_size=”large” css_animation=”fadeInLeftBig”][vc_column_text]Nell’ultimo capitolo, seguendo la parabola fisiologica dell’esistenza, l’universo delle donne e della letteratura viene osservato attraverso una particolare lente di ingrandimento: quella del tempo e del suo incedere inesorabile. L’immagine della vecchiaia come disvalore è un antico topos letterario. Già nel VII secolo a. C. il poeta elegiaco greco Mimnermo definiva la giovinezza oligochrònion, “dalla breve durata”, e la vecchiaia aischròn, “biasimevole”. Eppure, anche la vecchiaia, pur con le sue solitudini, con la decadenza del corpo e del desiderio, può essere una fase esistenziale produttiva: ancora una volta la Petrignani ci offre come esempio quello di una donna, di una scrittrice che, proprio in età matura, dopo il fallimento della propria attività imprenditoriale, “riannoda il filo di ambizioni artistiche giovanili” e diventa scrittrice: Karen Blixen. In Dagherrotipi, la Blixen osserva come la donna, al subentrare della vecchiaia, sia in grado di convertire la propria capacità seduttiva, depauperata dallo scorrere del tempo, in pratica magica, con cui esercita il proprio controllo sull’uomo che, da quest’ arte misteriosa, è attratto. Nello specifico, la pratica magica della Blixen, da lei appresa in veneranda età, è la letteratura. La letteratura, così, si colora di una nuova sfumatura, quella della fascinazione.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Maria Cristina Marino”][vc_single_image image=”9697″ img_size=”large” css_animation=”fadeInLeftBig”][/vc_column][/vc_row]