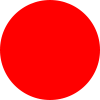Estate 1968, all’imbrunire. È un fine settimana. La terrazza si affaccia sul mare. Decine di persone consumano granite e aperitivi, in attesa dell’ora di cena. Cercano riparo dalla calura e dall’umidità dello scirocco sotto il porticato. Si gioca a bridge.
L’ampia pista da ballo rotonda è circondata da un filare di pali metallici, che sostengono la copertura. Ad ogni palo corrisponde una lampadina colorata.
Una rotonda sul mare, nello stile dell’epoca. Come una delle canzoni più in voga del momento.
Lo specchio d’acqua sottostante è anch’esso circolare, meravigliosamente calmo. Dalla parte opposta, ad oriente, si stende la parte antica della città. Le sue luci si specchiano nell’acqua, sdoppiando l’immagine.
Alcuni bambini stanno giocando attorno e dentro la rotonda, ai piedi del filare dei pali di sostegno. Hanno cinque o sei anni. Due di loro, da sempre i più vivaci, cominciano a risalire i pali come pertiche. Sono agili, rapidi; è probabile che abbiano più volte provato quel gioco per stupire i compagni.
Le luci sono state accese da poco; arrivare alle lampadine è il traguardo.
Uno dei due si arrampica veloce, raggiunge la luce rossa: è lì, gli basta allungare il braccio ed avrà vinto la sfida. La mano si protende, le dita sfiorano la lampadina; eccola. C’è un appiglio: il ferro di sostegno. Si aggrappa. Ha vinto!
Il filare di lampadine comincia ad emettere luce ad intermittenza. Il bambino è aggrappato, ma non si stacca. Una miriade di scintille lo avvolge. Le gambe gli restano appese in aria; le mani sono ancora lì, attaccate al sostegno. Dopo alcuni, lunghissimi secondi, il ferro lo respinge, ed il bambino cade nel vuoto.
Ora è per terra. Si guarda attorno, frastornato. La felpa che indossa emette del fumo, ha dei buchi. Il bambino si guarda le mani. Nella sinistra, sul palmo, ci sono due solchi rotondi. La pelle attorno è sfrangiata e bruciacchiata. Sente uno strano odore di carne arrostita, ma fatica a capire che proviene dalla sua mano. Non sente dolore, non piange. Non riesce nemmeno a capire se ha paura, o se l’ha provata prima. Ricorda solo un pensiero, che gli è rimbalzato in testa mentre non riusciva a staccarsi dal palo e sentiva quella scossa fortissima: “Questa è la prima volta che muoio!”.
Adesso sente una fitta all’avambraccio. Solleva la manica della felpa. Sul polso c’è un altro buco, simile a quelli sulle mani, ma più grande. La corrente lo ha attraversato per pochi centimetri, dal palmo al polso. Non si sa per quale favorevole gioco del destino non sia andata oltre. Non si sa perché non lo abbia ucciso.
 L’estate del 1968 è lontanissima, nel tempo e nei ricordi.
L’estate del 1968 è lontanissima, nel tempo e nei ricordi.
Quarantaquattro anni dopo, i bambini hanno giochi elettronici, cellulari touch screen, I-Pod.
La giornata è serena e la festa è allegra ai bordi della piscina. Il pranzo volge al termine ed in molti si concedono un gelato, in attesa del caffè.
Il richiamo dell’acqua è irresistibile per qualunque bambino, anche per quelli con l’I-Pod. In un attimo, sono tutti in costume. I più disinvolti sono già in acqua; subito è spuntato un pallone. I più riluttanti esitano, ma è facile prevedere che presto finiranno in acqua anche loro, spontaneamente, o per volontà altrui.
L’atmosfera è allegra, rilassata. La festa è riuscita, sia per i piccoli, che per i genitori. Tutti si sono divertiti ed hanno mangiato bene.
Si gioca, si scherza, ci si spruzza, si ride.
Due ragazzetti galleggiano dalla parte profonda della vasca, lì dove non si tocca. Uno entra ed esce dal bordo, per tornare a tuffarsi. E si tuffa, e si tuffa, e si tuffa. L’altro agita le braccia. E le agita, e le agita, e le agita.
Nessuno si è accorto che sta annaspando.
I lunghi capelli gli vanno davanti alla bocca. È nel panico.
Ma tutti gli altri giocano, si spruzzano, si tuffano, si passano la palla.
Il bambino annaspa; annaspa sempre di più.
Molti dei grandi sono a bordo piscina; alcuni guardano i propri figli, altri, in totale serenità, volgono loro le spalle e li lasciano giocare. Nulla può succedere.
Ma il bambino dai lunghi capelli ora non riesce nemmeno a tirar fuori la testa, la bocca.
Solo una donna lancia un allarme: quel bambino sta annegando!
Un uomo assiste alla scena. Non ci sono i suoi figli in acqua, non avrebbe nemmeno motivo di stare a guardare i bambini che giocano. Ma sa riconoscere e distinguere il gioco dal pericolo. Forse perché l’ha vissuto sulla sua pelle, così da vicino, tanti anni fa.
L’uomo si lancia; non importa che sia interamente vestito; non importa l’orologio, il cellulare in tasca. In un attimo è in acqua, accanto al bambino. Sa come prenderlo.
Lo afferra, lo solleva e gli consente di respirare. Lo appoggia al bordo e lo consegna agli adulti, a quelli che finalmente si sono accorti della tragedia che stava per compiersi.
Il bambino è spaventato, bianchissimo in viso, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. È sotto shock. Alla fine non ha corso alcun pericolo.
L’uomo si toglie i vestiti bagnati. In molti si avvicinano, lo ringraziano, si congratulano.
L’uomo si sfila la camicia e lo sguardo gli cade sul suo polso sinistro: sulla cicatrice.
Ma non vede la cicatrice, vede il buco con la pelle sfrangiata; sente l’odore di carne bruciata. Rivede la sua mano ed il suo polso da bambino, di quarantaquattro anni prima.
Rimane intontito, attonito, mentre ancora in tanti si avvicinano per manifestargli compiacimento e gratitudine. Ma lui non li sente più.
Per quarantaquattro anni si è portato dentro quella domanda: perché la corrente lo ha respinto, invece di ucciderlo?
Forse perché il destino voleva dargli un appuntamento.
Un appuntamento con un altro bambino.