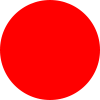“N’gnanzoù”, lo spettacolo di e con Vincenzo Pirrotta, portato in scena al Teatro Massimo di Siracusa, attraverso l’arte dei cunti e canti, “traduce” la fisionomia di una comunità di pescatori in parole di forte impatto estetico e in risonanze emotive per l’anima
La pièce, prodotta da Artelè e dedicata a Mommo Solina, l’ultimo grande rais, costituisce l’esito del viaggio di Vincenzo Pirrotta a Favignana e a Trapani, dove sostò sei mesi tra i “tonnaroti” e i “raisi”.
Vincenzo Pirrotta, che in quel periodo stava mettendo in discussione il suo mestiere di cantastorie, scrisse così il testo di questo spettacolo travolgente come un maroso, carezzevole come un flutto, un’ondulazione, un’increspatura. Nel testo, portato in scena da Pirrotta, affiancato da Nancy Lombardo e da Mario Spolidoro – autore anche delle musiche – c’è il terrore di una morte incombente, c’è la vita che il cielo in tempesta cancella in un niente, c’è la carne argentea che sanguina, trascinata, poi, dalla corrente.
E mentre il sipario si alza su un immaginifico vascello pronto a salpare, nel cielo di piombo, si innalza una preghiera (intonata da Nancy Lombardo): “E San Giuseppi vardali li nostri marinara, talìa chi celu ‘i ghiummu, in casa falli turnari; E San Giuseppe vardali li nostri marinara, talìa chi celu ‘i ghiummu, nun li fari affunnari. ‘Na Salvi Riggina matri di Dio rosario, ‘na Salvi Riggina matri di Dio calvario”.
Si sussegue così una fitta sequenza di dialoghi tra il cantastorie e l’altro attore, nonché tra il cantastorie, che si improvvisa puparo, e il suo burattino. “Rais, mi dicissi ‘na cosa, ma secunnu vui San Petru, ca era macari piscaturi, n’havi tempu di pinzari a nuàutri?”. “Secunnu mia penza ai dispirati”. “Ma pirchì nuàutri chi semu?”. “Quannu staiu ‘na para di jorna senza jiri a mare, è comu s’agghiurnassi senza alba, è comu se scurassi senza tramonto. Rais, cos’è quella specie di lamento che fanno i tonni nella camera della morte? Ju sempri ci penzu, a sta perversione della carne fatta pisci; quannu nuàutri sintemu ‘u ciauru di zagara, iddi si ni venunu cca, ppi truvari l’acqua cchiù caura, ppi truvari la fimmina e la puisia”.
Il crocchio, poi, affonda nella carne, e i tonnaroti tiravano n’gnanzoù, e i tonnaroti tiravano n’gnanzoù, e i tonnaroti tiravano n’gnanzoù. “E ju, quannu ‘n capu a li spaddi haiu ‘n mantu di tramuntana, quannu supra ‘a la terra mi sentu suli, mi ni vaiu dalla signora Isabetta e idda mi quaria”. “Ma è ‘na buttana?”. “Chi buttana e buttana! Chidda è fimmina cu lu cori granni”.
Un cunto al sapore di sale, scritto col sole e col vento, un’ondata di dolore, un racconto di abissi e di stelle, un fremito schiacciato dal destino. Ma si sa: “Quannu lu destinu nun t’aiuta, tu dummannacci cunsigghiu a la puisia”.