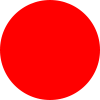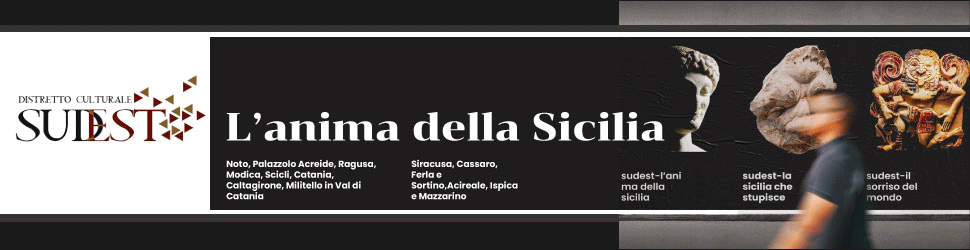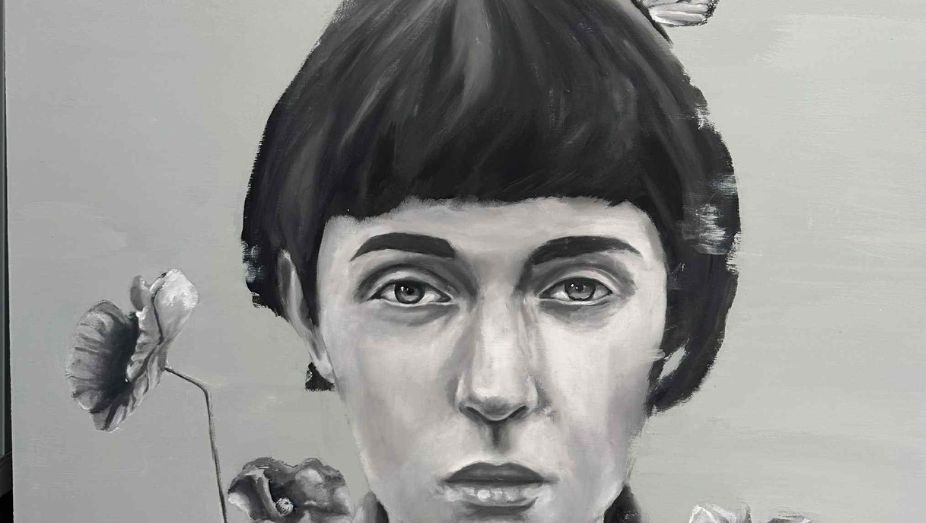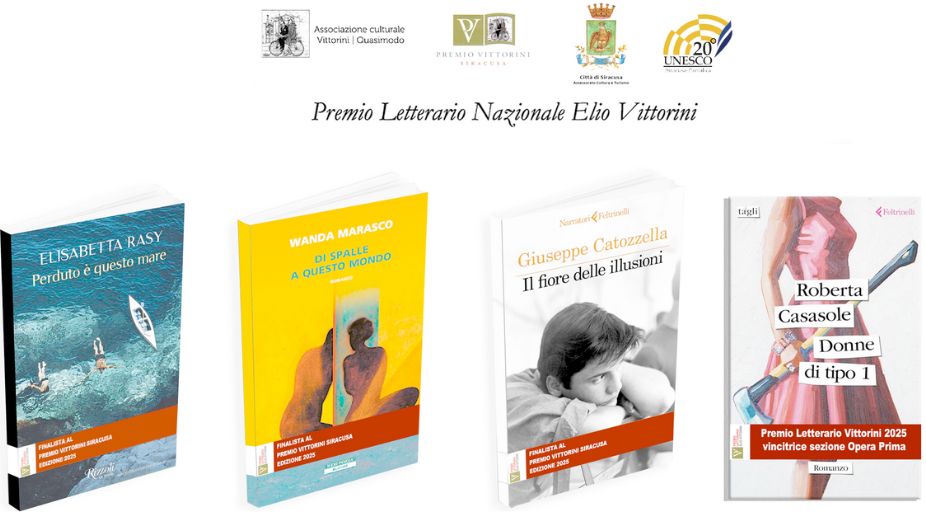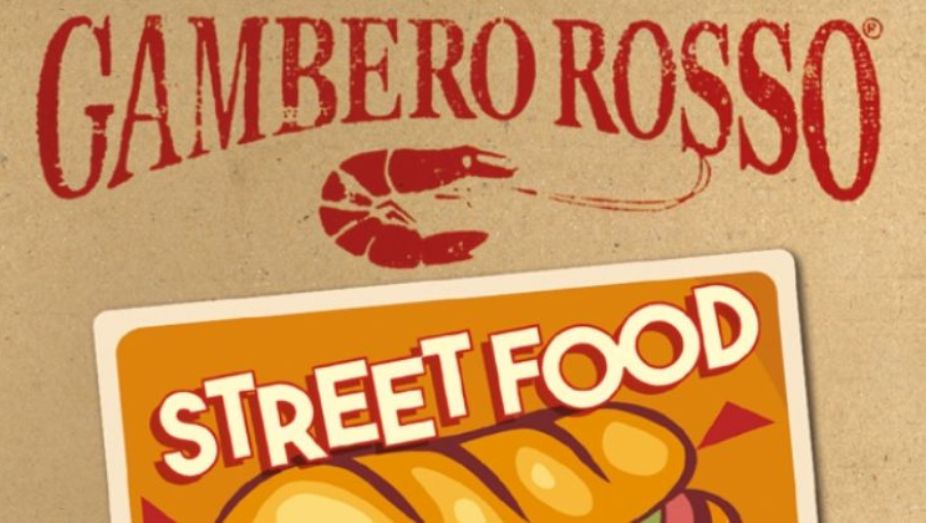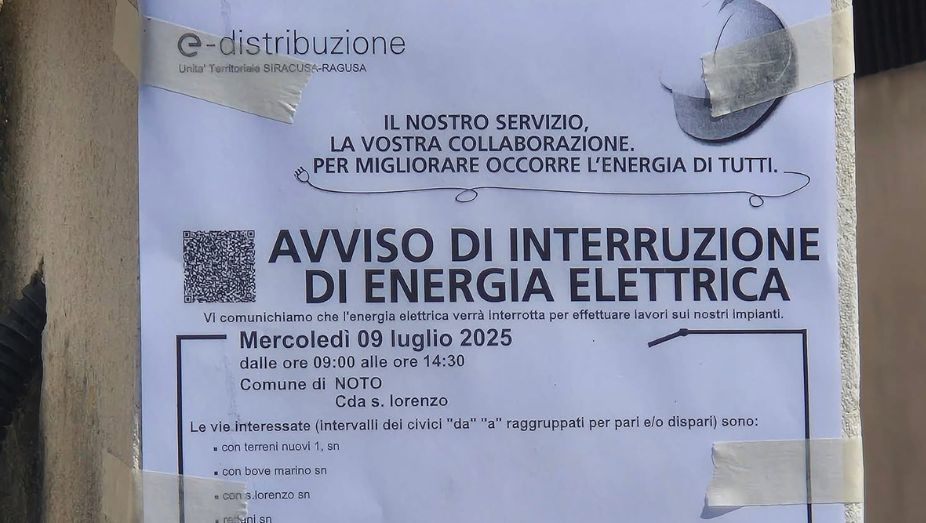[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Convivio, rubrica a cura di Mario Blancato”][vc_column_text]In genere gli studiosi pongono la nascita del pensiero greco, attorno al VII e VI secolo a. C., individuando i nomi di Talete, Anassimene, Anassimandro, nella Ionia asiatica, ma subito dopo aggiungono che non abbiamo le opere di tutti questi filosofi, perché – si dice –sono andate perdute. (oggi abbiamo solo i frammenti del Diels-Kranz, raccolti ne I presocratici pubblicati da Laterza).
La tradizione filosofica scritta e orale comincia invece con il V secolo, con le opere monumentali di Platone, di cui conserviamo quasi tutta la produzione. Ma ci sarebbe da pensare perché si sarebbe salvata solo questa produzione insieme con quella di Aristotele, suo allievo, mentre tutta la tradizione filosofica, per esempio, di Democrito, e di tutti gli studiosi di fisica, Epicuro, e centinaia di nomi legati all’empiria scientifica sarebbe stata tutta dispersa, ignorata e/o volutamente, distrutta, come io penso. Il mio Tradizioni di pensiero (Aracne 2016) lo dimostra in maniera inoppugnabile.
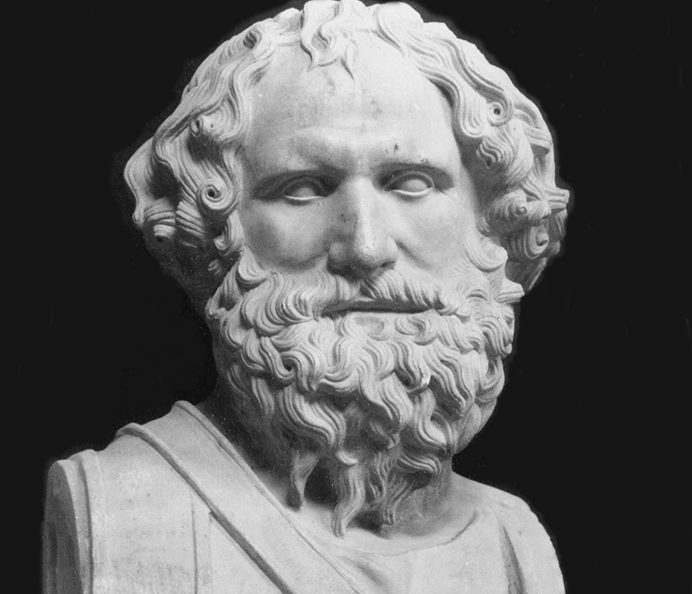 Ritengo, infatti, che la scomparsa di tutta la vasta produzione di Democrito e dei suoi successori non sia avvenuta per caso, cioè a causa di eventi sfortunati e maledetti. Penso, invece, che Platone e Aristotele si collochino dentro una tradizione di pensiero, che muove da principi, interessi politici, religiosi e sociali diametralmente opposti all’altra tradizione, entro cui si colloca Democrito. La filosofia occidentale si è mossa lungo quest’asse, cioè sull’asse centrale di Platone ed Aristotele, su cui si è innescato anche il pensiero cristiano di Paolo di Tarso, avendo tali filosofie una inclinazione spiritualistica e religiosa, basata sulla metafisica, e non sull’empiria scientifica di Democrito o Epicuro. Dante, per esempio, definisce Aristotele, il maestro di color che sanno o Raffaello nella Scuola di Atene pone Platone e Aristotele al centro della scena, mentre marginali e periferici appaiono Euclide, Archimede, Tolomeo.
Ritengo, infatti, che la scomparsa di tutta la vasta produzione di Democrito e dei suoi successori non sia avvenuta per caso, cioè a causa di eventi sfortunati e maledetti. Penso, invece, che Platone e Aristotele si collochino dentro una tradizione di pensiero, che muove da principi, interessi politici, religiosi e sociali diametralmente opposti all’altra tradizione, entro cui si colloca Democrito. La filosofia occidentale si è mossa lungo quest’asse, cioè sull’asse centrale di Platone ed Aristotele, su cui si è innescato anche il pensiero cristiano di Paolo di Tarso, avendo tali filosofie una inclinazione spiritualistica e religiosa, basata sulla metafisica, e non sull’empiria scientifica di Democrito o Epicuro. Dante, per esempio, definisce Aristotele, il maestro di color che sanno o Raffaello nella Scuola di Atene pone Platone e Aristotele al centro della scena, mentre marginali e periferici appaiono Euclide, Archimede, Tolomeo.
Quindi già nella Grecia, proprio a partire dal periodo aureo della civilizzazione greca, si sono andati differenziando due opposte tradizioni di pensiero, una che ha creato la dialettica (Platone) e la Teologia (Aristotele), che approdano al pensiero idealistico di Hegel, l’altra a partire da Pitagora, e poi con Euclide e Archimede, più materialistica, più empirica e più immanente, che riprende poi, come fiume carsico, fino a Galilei e a Newton e a tutta la fisica moderna e contemporanea.
In questo senso va letto ed interpretato l’Arenario di Archimede Siracusano, genio sommo dell’umanità del III sec. ucciso da un soldato romano, durante la conquista di Siracusa nel 212 a.C.
L’Arenario è, infatti, prettamente opera di matematica; ma se vogliamo capirla nella sua complessità è anche opera di aritmetica, di astronomia, di fisica, fonte di importanti e preziose notizie storiche nel campo della storia delle scienze, in particolare dell’astronomia, della matematica e della tecnologia scientifica; è insomma, a nostro modesto parere, opera di profonda portata culturale, filosofica ed epistemologica, non messa in evidenza dalle diverse letture che sono state date di esso.
L’opera, considerata nella sua integralità, smentisce inveterati luoghi comuni o pregiudizi sulla natura della cosiddetta scienza greca e sulla personalità di Archimede sia dal punto di vista filosofico e scientifico, sia dal punto di vista linguistico.
In primo luogo, l’opera smentisce il luogo comune di una scienza greca asettica, come quella che appare nel testo di Euclide, fatta di definizioni, assiomi e teoremi, senza humus culturale, nel momento in cui l’opera archimedea è scritta sotto forma di lettera ad un re, il re Gelone, di Siracusa, cui riconosce una certa competenza matematica e una certa conoscenza astronomica (cfr.
Arenario,I,3,4) e verso il quale si rivolge per impegnarlo nella lotta contro un pregiudizio o più pregiudizi, acritici e fideistici, diffusi nelle credenze religiose dei più, come dei poeti e dei filosofi, contro cioè quei pensatori che teorizzavano: “non possono esistere numeri che riescano a contare molteplicità grandi, quanto possono essere i granelli di sabbia del mare, ma anche quelli formanti tutto l’universo conosciuto”.
Si pensi al poeta Pindaro, del V secolo a.C., vissuto per un certo periodo nella Siracusa, che sarà poi la patria di Archimede, che già aveva scritto “ la sabbia sfugge il numero”(Ode olimpica,II,98) e a tutta la coeva o quasi, ad Archimede, letteratura religiosa biblica, osannante alla innumerabilità della sabbia del mare, il cui numero può essere conosciuto solo da una sapienza superiore all’uomo, che può essere solo quella di Dio (Tutta la sapienza viene dal Signore ed è con lui per tutti i secoli. La sabbia del mare e le gocce della pioggia e i giorni dei secoli chi può mai contarli? Uno solo è sapiente e molto terribile seduto sopra il suo trono: Dio. (Cfr. Bibbia, Ecclesiastico,1.1;1.6).
Opera quindi profondamente illuministica, ante litteram, tanto sulla scia del pensiero di Democrito, l’unico filosofo, che troviamo citato nelle opere rimaste di Archimede, il quale ha osato immaginare un universo omogeneo, dal punto di vista fisico-metafisico, un mondo formato di soli atomi fisici, come sono i granelli di sabbia, che Archimede immagina formanti il suo ipotetico universo fisico, di cui vuol contarne il numero, quindi che non è disomogeneo né gerarchico, come quello platonico ed aristotelico, quanto sulla scia del pensiero di Parmenide, secondo il quale il non essere né lo puoi pensare né lo puoi esprimere, per cui il pensare è lo stesso che l’essere (cfr.Diels-Kranz,28,B,2.5;B,3) come pure sulla scia del pensiero sofistico, di critica del pregiudizio, mitico e religioso acritico, non a misura d’uomo.
Solo chi sa osare pensare in modo matematico, che è come dire per Archimede, in modo razionale, conclude questi la sua opera, sa liberarsi dal pregiudizio, ovvero sa pensare e nominare numeri grandi quanto vuole e assegnarli a molteplicità esse pure grandi quanto si vuole, siano esse pure grandi quanto tutto l’universo che noi conosciamo. “Penso infine, o re Gelone, che tutte queste cose sembreranno non credibili ai più, che sono inesperti di cose matematiche, ma quelli che le coltiveranno e si applicheranno a conoscere le distanze e le grandezze della terra, del sole, della luna e del mondo intero, le ammetteranno a seguito della mia dimostrazione. Ed è per questo che io ho ritenuto opportuno che anche tu ne prendessi conoscenza” (Arenario, IV,20).
L’opera smentisce ancora l’altro pregiudizio del progredire della scienza greca in senso univoco, senza conflitti sul campo, di sola matrice platonico-aristotelica, specie nel campo dell’astronomia, nel momento in cui porta la testimonianza di un sistema eliocentrico, quale quello di Aristarco, III a.C., di tutt’altra matrice, pitagorico- democritea, cioè di un universo non solo non geocentrico, come quello del pitagorico Filolao, ma anche non-finito ed acentrico, come quello di Democrito.
Ma l’opera smentisce soprattutto l’inveterato pregiudizio, duro a morire di una scienza greca, prettamente teoretica, contemplativa, idealistica, slegata dalle operazioni fisiche di misura come dall’uso di strumenti tecnici di misurazione.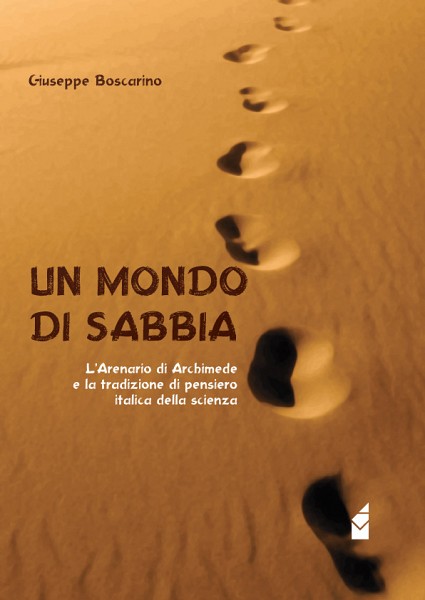
L’opera è stata scritta in lingua dorica, anzi in dialetto il dorico-siracusano. L’opera testimonia allora che c’è stata una scienza autoctona, con molti poli, uno dei quali è stato Siracusa, con una sua tradizione culturale pitagorico- democritea (ricordo Iceta ed Ecfanto siracusani e pitagorici, che, già nel V-IV secolo a.C., secondo le testimonianze, parlano di rotazione della terra attorno a sé stessa, come di una realtà formata da atomi fisici, indivisibili, monadi quindi in senso antiplatonico ed antiaristotelico –(Cfr. D.K. 51,2);
Ha scritto lo studioso Antonio Quaquarelli sulla fortuna di Archimede nei retori e negli Autori cristiani antichi: “La lingua, in cui sono scritte le opere di Archimede, ha perduto ogni traccia delle
sue forme di origine. Se il dialetto ionico si adattava alla medicina, l’attico, alla filosofia e alla storia, il dorico della Sicilia, invece, si adattava alla scienza di Archimede. Anzi lo studioso tedesco Heiberg ha osservato con una metodica osservazione sugli scritti archimedei, cercando di risalire alle forme originarie, ha potuto dedurre che solo l’Arenarius si avvicina al dorico-siracusano, mentre tutte le altre hanno sofferto aggiunte e mutazioni da parte di un interpolatore che conosceva il dorico.
Questo pertanto ci può portare a parlare di una scienza non greca, ma mediterranea, del Mediterraneo centro orientale, acentrica, con tradizioni di pensiero in conflitto, primo tra tutti, tra la tradizione di pensiero pitagorico-democritea, a cui riteniamo che idealmente appartengano i siracusani Iceta e Ecfanto, e quindi il nostro Archimede, e quella platonico-aristotelica, contro cui nella sua opera combatte, nella fattispecie nella sua opera, l’Arenario.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Giuseppe Boscarino”][/vc_column][/vc_row]