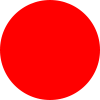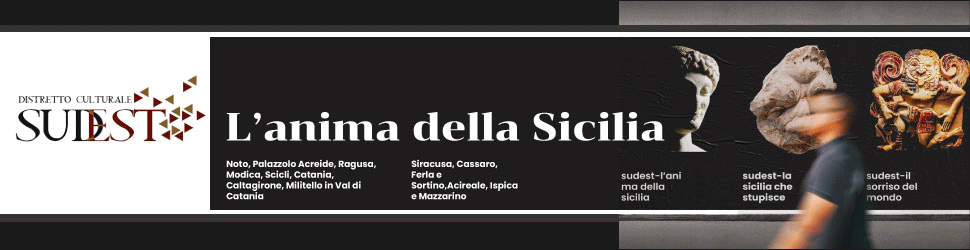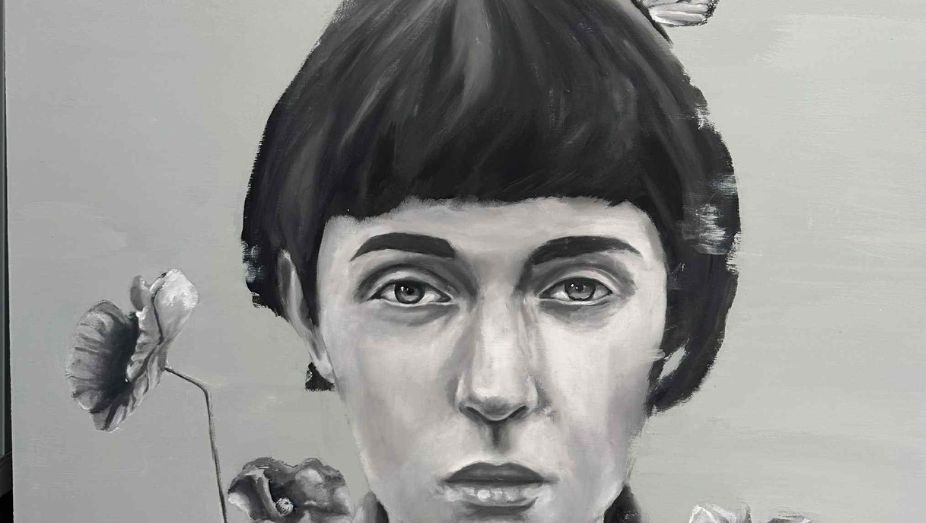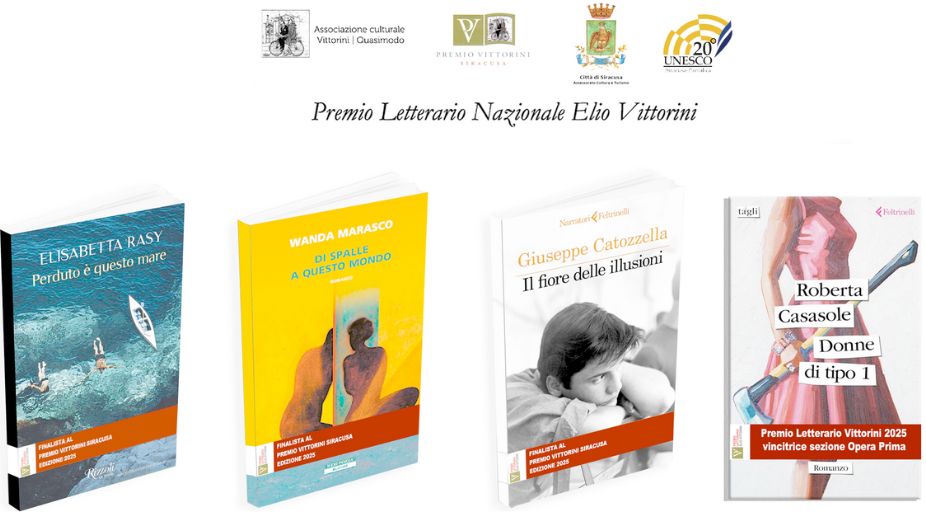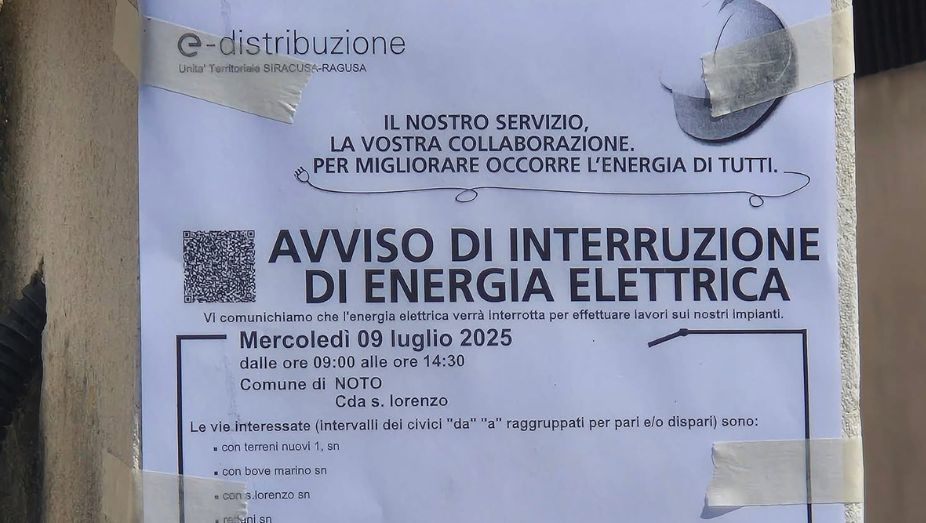[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11140″ img_size=”large”][vc_text_separator title=”Convivio, rubrica a cura di Mario Blancato”][vc_column_text]Il rapporto tra la Russia e l’Europa è un tema centrale nella riflessio-ne dell’Ottocento. Con una sorprendente ricchezza culturale, gli in-tellettuali russi, sia sul versante politico che su quello letterario, si sono interrogati sulla natura del loro Paese, individuandone un per-corso simile a quello dell’Europa o evidenziandone una identità “al-tra”, a volte “totalmente altra”, fondata su realtà spirituali e culturali sostanzialmente diverse.
Anche la storiografia occidentale ha scrutato la Russia, un paese immenso e atipico, portatore di una cultura affascinante, ma sempre legato ad una logica particolare, difficile da comprendere. Si ritiene, secondo le interpretazioni dominanti, che questo Paese da secoli ab-bia cercato la via di una completa europeizzazione, ma alla fine abbia seguito un percorso del tutto peculiare, molto spesso tragico ma mai insignificante. Il suo rapporto con l’Europa è stato costantemente duplice e ambivalente, di attrazione e di ripulsa, di omogeneità e di alterità. Da qui deriva la tesi che la Russia è al tempo stesso Europa e Anti-Europa, Paese cristiano e “scismatico”, romantico e illuminista, progressista e conservatore.
Tramite la lettura di alcune opere, in questo contributo ricostrui-sco, nelle linee generali, le riflessioni di Dostoevskij sul rapporto Russia-Europa. Per gli slavofili, la polarità Russia-Europa si concre-tizza in due modelli di vita diversi. Dostoevskij, al contrario, parte dall’esperienza sociale e dalla capacità di avvertire «la frattura con il passato», la crisi di tutti i valori tradizionali e la mancanza di nuove «idee unificatrici». «Il vincolo di un’idea che unisca gli uomini – di-chiara uno dei protagonisti del romanzo L’adolescente [Podrostok] del 1875 – è scomparso completamente». Un altro personaggio della stessa opera, Andrej Versilov, osserva che, con la caduta del feudale-simo, il precedente legame di idee si è disgregato e ha prodotto
l’affermazione dell’egoismo: «sono rimaste – afferma – solo le libere individualità». Nell’ambito di tale crisi vanno collocate le drammati-che vicende dell’«uomo del sottosuolo», dei Roskol’nikov e della fa-miglia Karamzov. Per tali ragioni, si può sostenere che Dostoevskij, tramite il confronto tra Europa e Russia e con la sua visione genial-mente penetrante, riesce a individuare i conflitti fondamentali e le tensioni esistenziali dell’uomo contemporaneo.
 L’utopia di Dostoevskij si racchiude in sostanza nella protesta contro la civiltà capitalistica. A differenza degli slavofili, che hanno coniugato posizioni conservatrici e populiste, il pensiero dostoev-skiano concentra l’attenzione sulle contraddizioni, sulle nuove con-dizioni di vita, sugli individui rosi dall’ambizione che possono tro-vare alimento solo nella dissoluzione della gerarchia sociale costitui-ta. Sotto questo aspetto, molte delle considerazioni di Dostoevskij sono ispirate non tanto dagli slavofili, ma dalle idee di Herzen. Al-cune convergenze tra conservatori e socialisti nella critica al capitali-smo sono in effetti una delle costanti dell’evoluzione del pensiero so-ciale del secolo XIX.
L’utopia di Dostoevskij si racchiude in sostanza nella protesta contro la civiltà capitalistica. A differenza degli slavofili, che hanno coniugato posizioni conservatrici e populiste, il pensiero dostoev-skiano concentra l’attenzione sulle contraddizioni, sulle nuove con-dizioni di vita, sugli individui rosi dall’ambizione che possono tro-vare alimento solo nella dissoluzione della gerarchia sociale costitui-ta. Sotto questo aspetto, molte delle considerazioni di Dostoevskij sono ispirate non tanto dagli slavofili, ma dalle idee di Herzen. Al-cune convergenze tra conservatori e socialisti nella critica al capitali-smo sono in effetti una delle costanti dell’evoluzione del pensiero so-ciale del secolo XIX.
Sui rapporti tra la Russia e l’Europa, particolarmente interessanti sono le considerazioni sviluppate nel suo Diario, scritto negli ultimi anni della sua vita. Qui si colgono delle modifiche in ordine al suo atteggiamento di fronte all’Europa ma anche di fronte alla stessa Russia. Già nella rivista «Vremja», lo scrittore ha individuato la pecu-liarità del messianesimo che non respinge gli «dei stranieri», ma at-tribuisce al popolo russo il compito supremo di una riconciliazione universale: riconciliazione dell’Europa con la Russia, dell’intelligencija con il popolo. Nel 1877 le stesse idee sono così svi-luppate nelle riflessioni del Diario dal titolo Confessioni di uno slavofi-lo: «Oh se sapeste – così egli scrive nel 1877 – quanto è cara a noi, so-gnatori-slavofili, l’Europa, quella stessa Europa che, secondo voi, noi odiamo, quel “paese dei sacri prodigi”. No, ci è caro questo paese e la futura pacifica vittoria del grande spirito cristiano, che si è conser-vato in Oriente […]. Temiamo che l’Europa non ci capisca e come
prima, come sempre, ci accolga con alterigia e disprezzo e con la sua spada, come barbari selvaggi, indegni di parlare davanti a lei».
Dostoevskij non può mutare radicalmente atteggiamento senza rinnegare quella fede nella Russia. Nel gennaio 1877, scrisse un arti-colo dal titolo Un sogno di conciliazione fuori della scienza, meritevoli di essere posto come epigrafe del Diario: «Ogni grande popolo crede e deve credere, se vuole restare a lungo in vita, che in lui, e soltanto in lui è racchiusa la salvezza del mondo e che vive per essere alla testa dei popoli, attrarli tutti a sé e portarli in un coro armonico, a uno scopo definitivo, a loro tutti predestinato».
Il Diario, quindi, offre molti elementi per la comprensione della personalità di Dostoevskij. Una sintesi delle sue ventennali medita-zioni si trova nella famosa orazione su Puškin, pronunciata l’8 giugno 1880, in occasione dell’inaugurazione del monumento al poeta, a Mosca. Lo stesso filo conduttore si trova in Evgenij Onegin. Il giovane dandy ozioso, «l’eterno vagabondo» disilluso dalla vita, trova nell’amore per Tat’jana, legata alle tradizioni spirituali natie e al po-polo, la soluzione alla disperazione e ai dubbi. Puškin, nel confronto incessante tra i «vagabondi russi» e la «verità popolare», indica una soluzione: «Se ti vincerai e ti umulierai, diventarai libero, come non hai mai immaginato che si possa essere, e inizerai la grande opera di dare la libertà agli altri, e conoscerai la felicità, perché la tua vita si riempirà e tu comprenderai finalmente il tuo popolo e la tua santa verità». Tutta l’opera puškiniana appare a Dostoevskij come un con-fronto incessante tra i «vagabondi russi» e la «verità popolare», che presuppone la necessità di avvicinarsi al popolo.
Il «ritorno alla patria», però, non comporta la rinuncia a un ideale universalistico. Puškin è scrittore profondamente nazionale, ma ca-pace di incarnarsi in una nazionalità straniera. Questa sensibilità egli la condivide con il popolo: essere un vero Russo equivale a diventa-re, come risultato ultimo, fratello di tutti gli uomini, uomo universa-le. Ne consegue che la divisione fra slavofili e occidentalisti è solo un equivoco, anche se un equivoco storicamente necessario e legittimo. Il senso riposto delle riforme di Pietro il Grande sta proprio in ciò,
nell’allargamento delle relazioni della Russia con i popoli europei. «Perché? – si chiede lo scrittore – cosa ha fatto politicamente la Rus-sia durante tutti questi due secoli se non servire l’Europa, servirla, forse, meglio più di se stessa?».
Dostoevskij, nel suo discorso, ha scelto la via della pacificazione e cita gli avversari con cui da anni è in competizione (Turgenev, Nekrasov e anche Tolstoj). Come ai tempi di «Vremja», tenta di con-ciliare slavofili e occidentalisti, indicando in Puškin «un grande mi-stero» e un’eredità. Indica, quindi, la sintesi profetica tra patriottismo autoctono e apertura all’Europa: «Sì, la missione dell’uomo russo è indubbiamente paneuropea e universale. Diventare un russo autenti-co, diventare pienamente russo, forse, significa solo diventare di tutti gli uomini, paneuropeo, se volete. […] A un vero russo l’Europa e il destino di tutta la grande razza ariana stanno a cuore quanto la Rus-sia stessa, quanto il destino del proprio paese, perché il nostro destino è l’universalità, acquistata non con la spada, ma con la forza dell’aspirazione fraterna nell’unione di tutti gli uomini».
Dostoevskij, con questo discorso, sembra convinto che sia arrivato il momento della riconciliazione generale all’interno del Paese e tra la Russia e l’Europa sulla base della comune fratellanza. È, questa, un’utopia o una sfida, che resta ancora aperta, come tanti altri pro-blemi sollevati da Dostoevskij nella sua opera letteraria.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Giuseppe Astuto”][/vc_column][/vc_row]